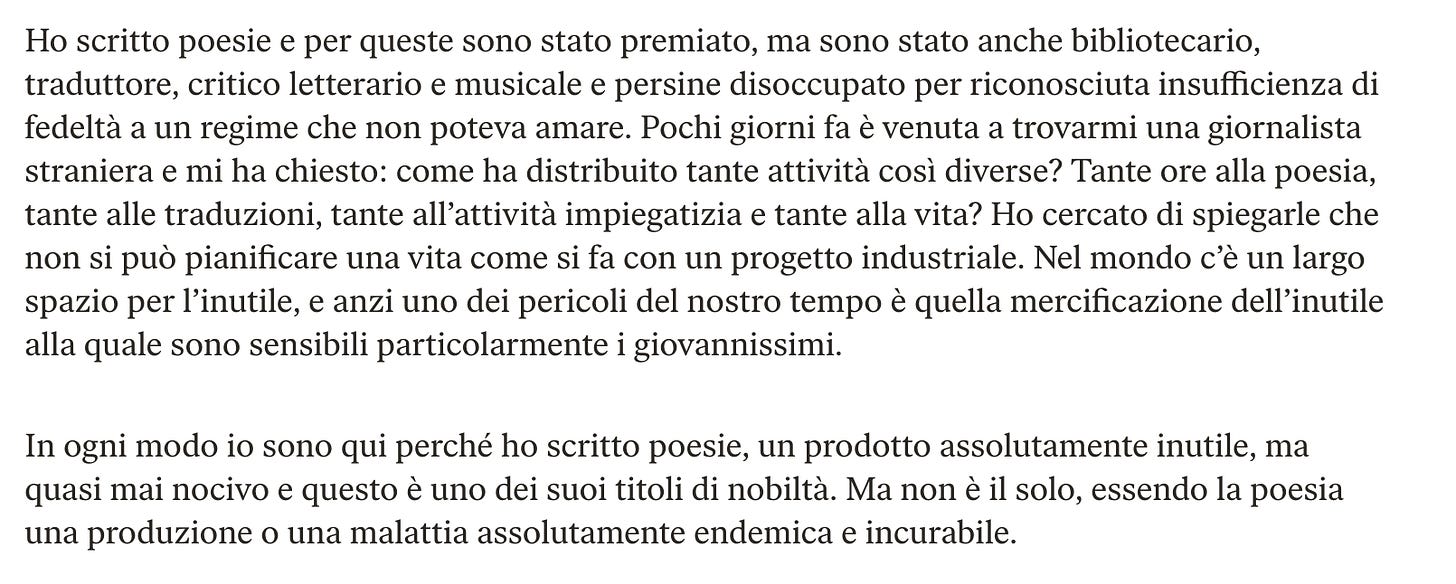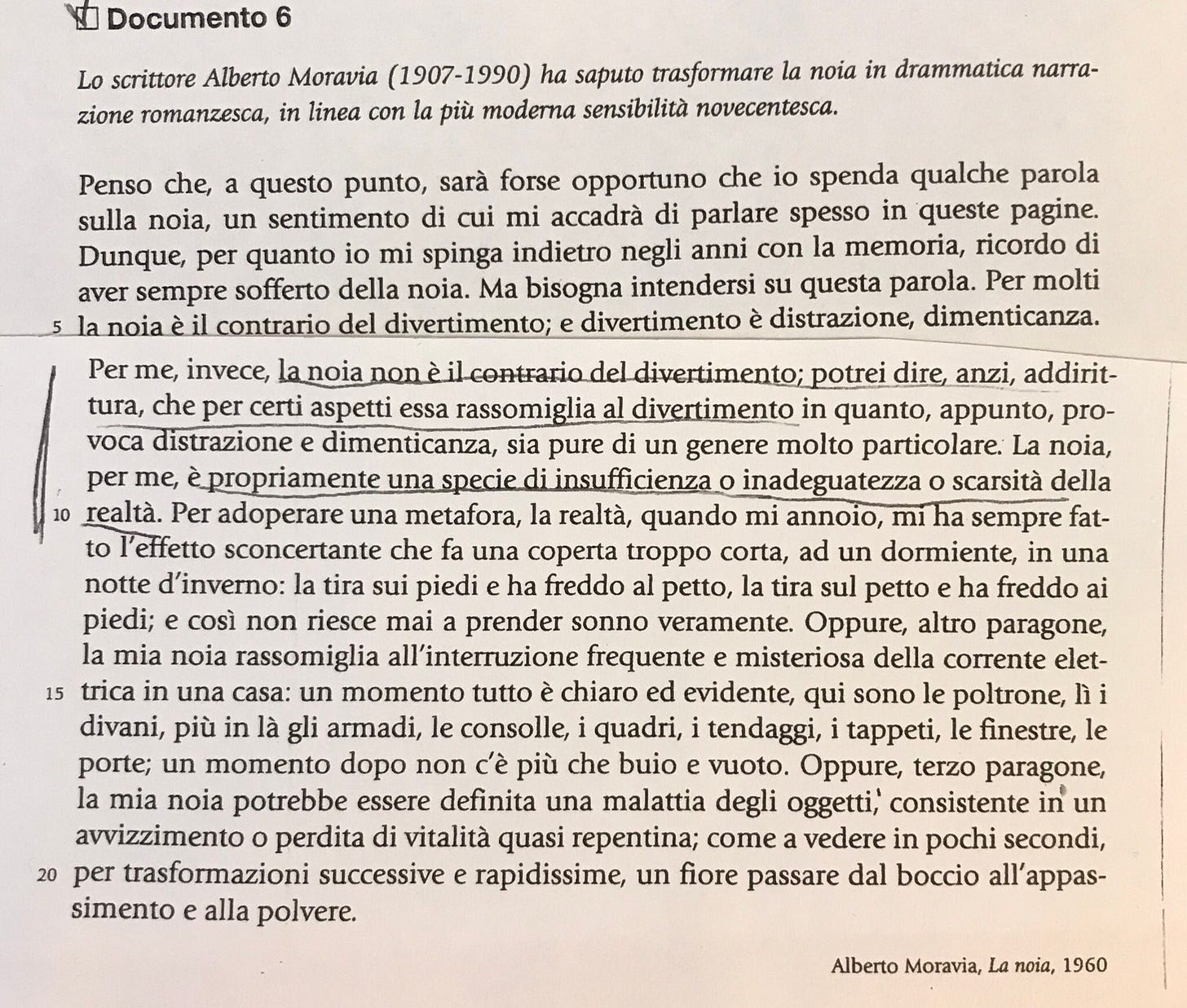L’ho fatto di nuovo. Nessuno spot, nessuna novità da portarsi a casa.
Nessun podcast di cui parlare con gli amici all’apericena per sembrare interessanti.
Solo la vita. Un pezzo della mia almeno.
Perché in fondo penso che ci sia dell’universale in ogni particolare.
Le spalle sono la parte del corpo che fa più male.
Ho tenuto le braccia spinte verso il cielo per troppo tempo.
Ho strappato lembi di pelle che appartenevano ad un’altra vita
usando tutta la forza che avevo sapientemente conservato.
Ho consumato le unghie,
e ridotto le mani ad un cumulo di ossa inservibili.
L’ho fatto per portare luce.
E sto qui, mentre riassetto il corpo sotto il peso del dolore,
a chiedermi se averlo speso ha cambiato davvero le cose.
Se il sacrificio ha sortito un qualsivoglia effetto.
Nella vita degli altri, sia chiaro.
Perché nella mia l’ha portato.
E le dita che toccano i tasti,
bestemmiando ad ogni vocale, me lo ricordano.
Battitura dopo battitura.
Devo essere utile.
Devo sentirmi utile.
Non capisco mai dove finisce la pena che mi auto infliggo e dove inizia la richiesta del resto del mondo. Quella infinita lista di compiti da svolgere, che la mia stessa nascita ha giustificato, e che, unica e sola, mi rende degna di considerazione.
A quanto pare ho un ruolo prestabilito in questa sceneggiatura. Un ruolo consegnatomi in eredità da qualcuno a cui volevo molto bene e che mi ha lasciato presto. Un ruolo generato per osmosi, quindi, e che per puro masochismo dello scrittore non evolve.
Non muta, pur nel mutare degli eventi.
Non cresce, pur subendo il passare del tempo.
Non ha sconti di pena, pur davanti a un conto
che ha superato il limite ben più di una volta.
Riempio vuoti.
Vuoti d’aria, di insufficienza emotiva, di mancata appartenenza.
Vuoti normativi, che concedono spazio ad interpretazioni sbrigative.
Vuoti di memoria, che gettano ombre sul luogo da cui provengo
e sulla sostanza di cui sono fatti i miei sogni.
Vuoti di assenze premeditate e indifferenti a qualsiasi forma di conseguenza.
E abiezione.
Mi do un senso e mi concedo un contegno scavando nelle necessità che mi gravitano intorno e trovando un modo per cancellarle, per porgli rimedio. Pare sia questo il motivo per cui sento di essere venuta al mondo. Per restituire un ordine alle vicende, agli umori, alle future proiezioni.
Giocando a rimpiattino con le incertezze, aspettando di vederle sbucare per ridergli in faccia, alla luce della mia indomabile capacità di avvistarle nella distanza.
Che fastidio doversi sentire utile.
Mi piacerebbe imparare ad essere.
Vorrei essere.
Inutile.
Come era inutile la poesia per Montale.
Estratto dal testo integrale del discorso di accettazione del Nobel per la Letteratura
tenuto da Eugenio Montale a Stoccolma nel 1975.
Inutile.
Come cercar di far rivivere
quel che c'è rimasto dentro
tanto di emozioni.
Per dirla come l’ultimo Jannacci.
Inutile
Come la noia per Moravia.
Dove vorrei che mi aspettasse e mi spettasse amore trovo solo la fatica.
E io perdo così ogni nome e il lustro di ogni cognome.
Finché quel che ho da fare è più di quello per cui posso essere,
nessuna terra mi potrà mai ospitare,
nessuna porta si potrà mai spalancare per dirmi che è finita;
che finalmente vivo perché sono e non perché ho compiti da consegnare.
Non ci sono più voti né insegnanti da venerare,
porto a memoria i miei guai e non li lascio trapelare,
eppure conosco palmo a palmo i disagi della gente,
gente a cui io non posso che importare meno di niente.
Forse solo
imparando ad essere
inutile ad uno scopo
ma abile alla vita,
si può scoprire il vero senso
dell’utilità.