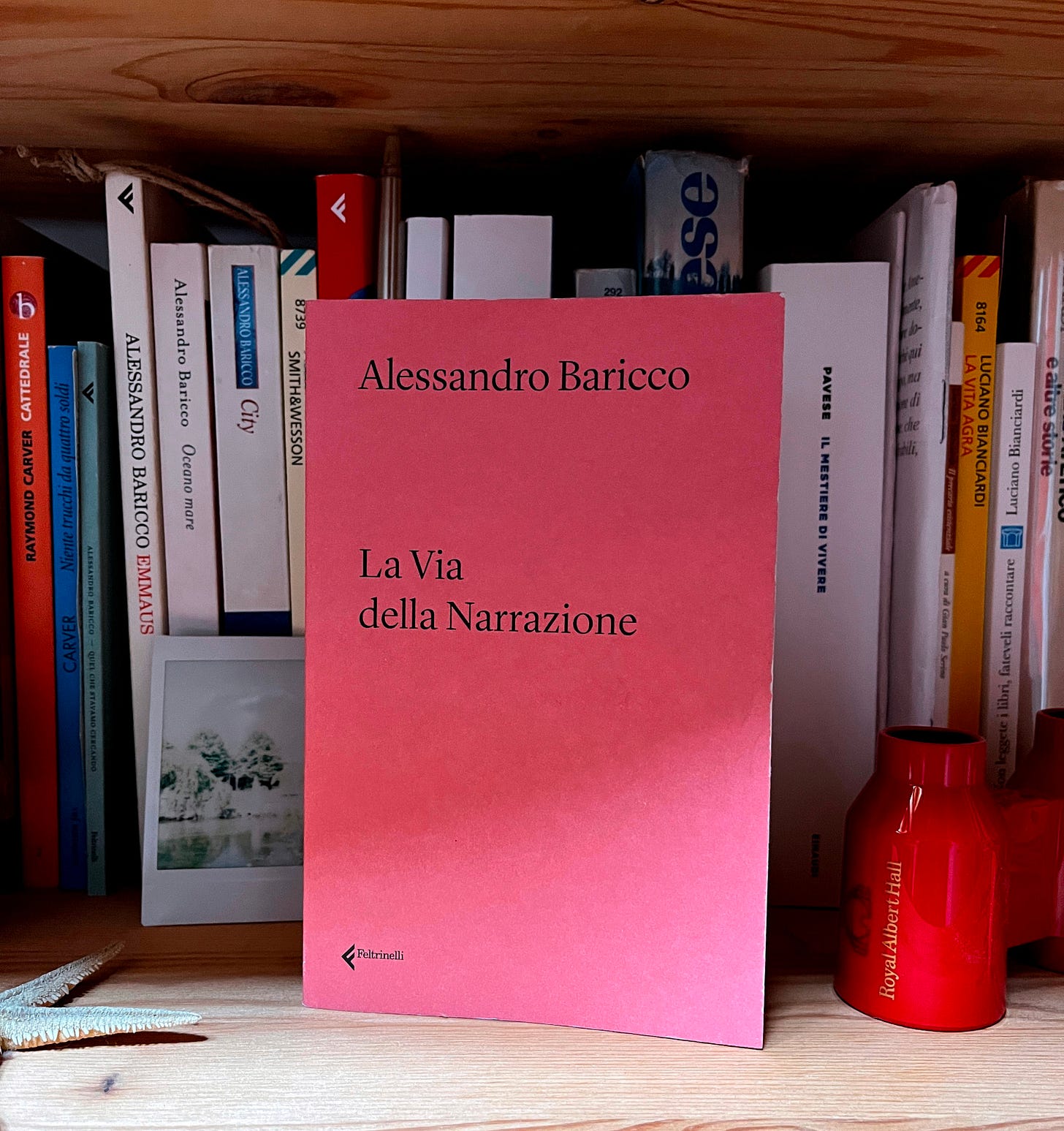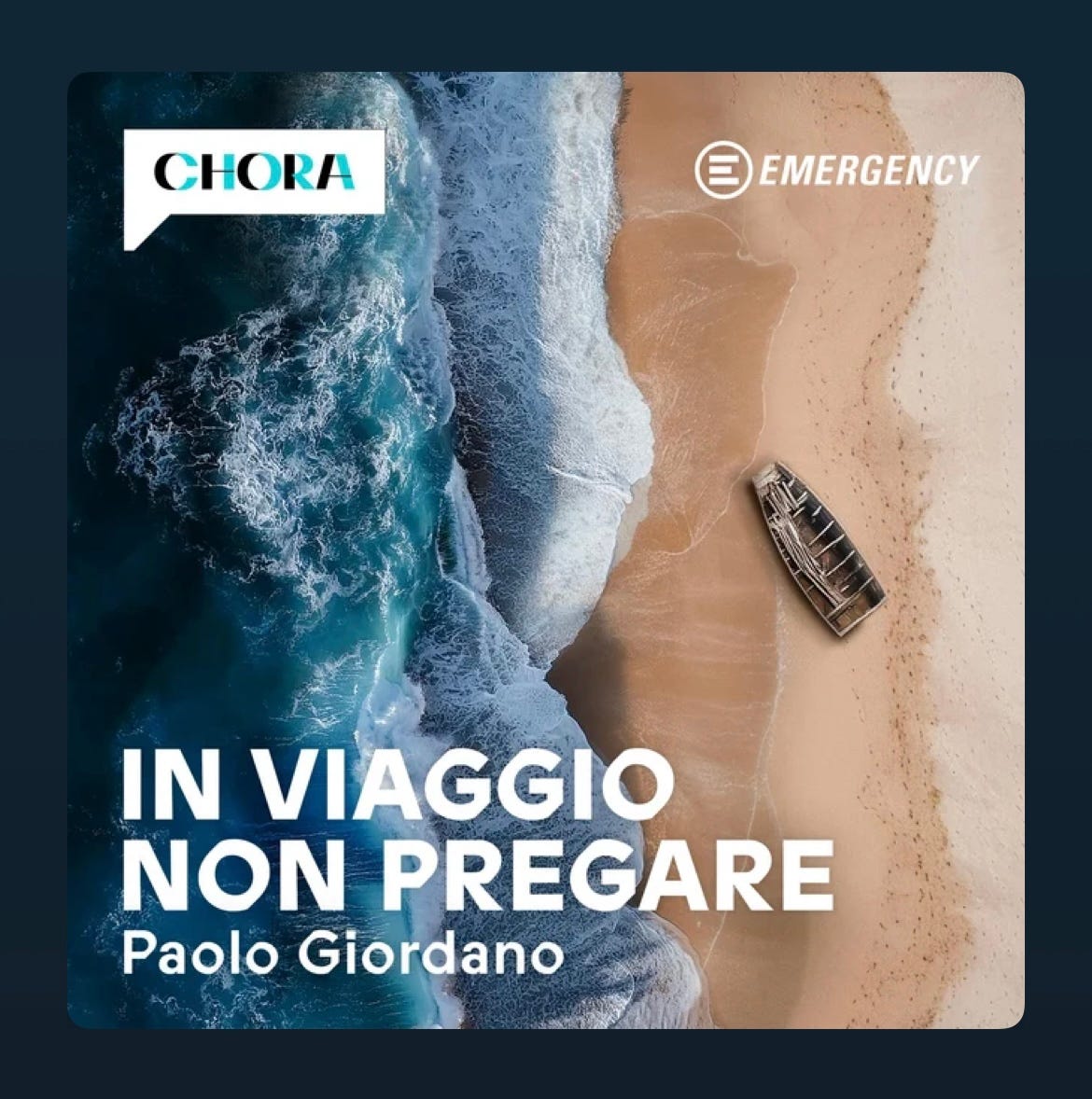Le prime preghiere le ricordo non recitate ma cantate. La mia voce da mezzo soprano si è allenata per anni inviando messaggi nell’alto dei cieli, e chiamando la pace in terra solo -sia inteso- per gli uomini di buona volontà.
Per questo mi ha colpito tanto la modernizzazione delle vecchie preghiere recitate.
Il riferimento alle tentazioni reso più blando, dissipando l’idea di un tranello strategicamente ordito, e il maschile sovraesteso ridimensionato per far posto al corrispettivo femminile. Così come i santi che in ogni tempo furono graditi hanno accolto al loro fianco quelli divenuti tali pur essendo di estrazione laica.
Ma la mia memoria più vivida a riguardo sarà sempre quella del pentagramma impresso sul foglio, in accompagnamento alle parole. Erano preghiere di cui percepivo la forza, l’intensità. Erano preghiere in cui godevo della gioia della partecipazione prima ancora di percepire il conforto del possibile desiderio esaudito. Perché le preghiere erano e sono state per me parte di un rituale collettivo, prima di diventare qualcosa di estremamente personale. La meditazione notturna di un overthinker professionista.
Le preghiere erano, per me, storie condivise. Storie cantate e narrate. E come dice Alessandro Baricco ne La Via della Narrazione: Narrare è l’arte di lasciar andare una storia, una trama e uno stile nel flusso di un unico gesto. Il suo scopo è tenere insieme cielo e terra.
Tenere insieme. Cielo e terra.
Infatti anche gli inni nazionali hanno sempre suonato un po’ alle mie orecchie come una preghiera laica.
In molti ci sarebbe da condannare l’intento bellicistico o la genuflessa richiesta di celeste benedizione ma non si può non riconoscere, nella composizione lirica e musicale, l’intrinseca volontà di tessere un filo invisibile tra le persone, che le richiama all’appartenenza come in un imprinting di massa. È lì che, nel bene o nel male, si percepisce sempre un noi. Ci si augura patriottico e non nazionalista.
È il noi che guida il preambolo costituzionale americano, We the People of the United States. Noi, il popolo degli Stati Uniti d’America. Non altri. Noi, quelli che -dice la dichiarazione d’indipendenza - sono dal creatore dotati di certi inalienabili diritti, tra cui quello al perseguimento della felicità.
Scevri da giudizi politici, sociali ed economici in vista del prossimo caldo novembre, la sentite anche voi la trama, lo stile e il flusso di qualcosa che prima ancora di essere regola vuole essere preghiera collettiva?
Il preambolo della nostra costituzione? L’articolo 1. Che definisce l’Italia una Repubblica Democratica. Una res publica, ovvero una forma di governo fondata sulla sovranità popolare, certo. Ma solo se conosci l’etimologia della parola. Una forma di governo che concede al suo popolo, prima di tutto, l’inalienabile diritto al lavoro. Perché chi non lavora, non fa l’amore.
Non so voi, ma io percepisco una certa differenza.
Sarà per questo che sono stati tre statunitensi a immaginare e realizzare l’applicazione Hallow, una sorta di Headspace per pregare da soli o con amici e parenti lontani, lanciata con uno spot durante il Super Bowl di quest’anno.
Il voice over è in effetti una preghiera, come quella che si recita prima di cenare nei film americani, ma esattamente come nei film americani, ha il suono un po’ sciovinista dei national anthem e finisce con la call to action stay prayed up che rischia di trasformare la quaresima in un nuovo black friday.
È un tentativo, di lucrare certamente, ma anche di rimettere insieme i pezzi. Di riallacciare i nodi tra cielo e terra. Di restituire comunità alle preghiere, ricordando le preghiere alle community. Con una comoda notifica sullo schermo del proprio smartphone.
In quest’ottica mi ha colpito molto quello che racconta Paolo Giordano nel podcast di Chora Media per Emergency che si intitola In viaggio non pregare.
Uno dei migranti a bordo della Life Support spiega infatti, a parole sue, che l’Islam prevede esenzioni dalla preghiera durante il movimento: travel, not pray. L’esenzione dalla preghiera classica, ovviamente, non un abbandono del divino. Ma pur sempre un’esenzione.
Insomma, durante i viaggi della speranza a volte la preghiera si spezza. Sintetizzo.
Perché in quel contesto non c’è gioia di esecuzione, non c’è senso di comunità trovata o perduta che tenga. Per quanto l’immensa gratitudine, dopo il salvataggio, possa farti improvvisare invocazioni di ringraziamento che farebbero invidia ad apostoli e ghost writer.
Ma pregare è un’altra storia, è un atto di natura differente che prevede di affidare le proprie richieste a qualcuno altro, per provare a raddoppiare le forze, immaginando qualcosa che sa di miracoloso.
Ho il timore che quando la salvezza ricercata è reale e non metaforica, raggiunta solo strappando dal mare e dalla morte corpo e anima, diventi oltremodo vano chiedere miracoli calati dall’alto e conti solo l’accettazione del proprio status di condannati. Condannati a non poter contare su forze diverse dalle proprie. Su forze diverse dall’umano.
E allora, si salvi chi può.
Provi a salvare gli altri, quand’è al sicuro.
E poi si metta a pregare, se ci riesce.