Sono nata in un mondo in cui la verità era un dato di fatto. Aveva i contorni delle risposte ai tuoi “perché”, date con dovizia di particolari da genitori stanchi ma consapevoli che, se ti avessero detto delle castronerie, tu le avresti portate in giro per il resto della tua vita.
E ho detto mondo, usando un’espressione geografica, anche se mi riferisco al secolo scorso: il pianeta Novecento, popolato da misteri gloriosi, come quello sulla strage di Ustica, di cui tutti -e dico tutti- pensavano di conoscere la chiave di lettura più veritiera. Tant’è che non si sono stracciati le vesti quando qualcuno ha deciso di farne l’ipotesi più accreditata.
Sono stata lì, ecco. Su quel pianeta. E ora sono qui. In un tempo (a questo sì che riconosco l’identità di qualcosa di volatile e passeggero) in cui ogni verità personale sembra poter essere presentata come verità universale, rischiando che qualcuno - in assenza di prove o al cospetto di ignoranze malcelate- le segua senza farsi afferrare al collo dal dubbio.
Credo che abbiano un loro concorso di colpa, in questa nuova procedura di approccio alla verità, l’incertezza imperante, di cui a quanto pare siamo diventati più consapevoli solo recentemente, e il senso velocizzato della vita che passa. Che poi sono parenti stretti.
Mario Calabresi, intervistato da Michele Lupi nell’ambito della rassegna C’è da fare dedicata alla salute mentale dei più giovani, ha presentato il suo ultimo libro “Il tempo del bosco”, un titolo che si riferisce prima di tutto all’esperienza del suo soggiorno nell’eremo di Camaldoli. A colpirlo è stata, tra le altre cose, la lentezza con cui i frati declamavano le lodi del mattino. Lentezza che, secondo don Ubaldo, serve alle parole per ritrovare il loro tempo. E la loro verità, aggiungo io.
Probabilmente è per questo motivo che ho pensato di aver bisogno di tempo. Di tempo speso diversamente, con altri ritmi, scandito da altre battute. Perché inizio ad inseguirla più di quanto abbia mai fatto prima, la verità. Cresciuta con l’idea che avesse come unico oggettivo quello di incontrovertibile, adesso sono pronta a barattarla con una pretesa. Purché sia la più onesta possibile.
E allora ho iniziato a chiedermi quante volte penso di averla incontrata, ultimamente. La verità.
La verità messa in scena.
È verità quella a cui si riferisce Jamie Lee Curtis nel podcast Real Ones realizzato da Jon Bernthal, suo collega in The Bear. L’aver sofferto in passato di dipendenza da oppiacei, aver cercato di nasconderlo per tutta la vita riuscendoci benissimo e aver poi deciso di uscire allo scoperto, affrontandone ogni forma di conseguenza, passandoci attraverso con ogni cellula del proprio corpo, le permette di portare nei suoi personaggi, nel loro spessore e nella loro terrena follia, qualcosa di puro e autentico. Perché tutto si può fingere, anche il dolore, ma solo se lo hai conosciuto veramente puoi portarlo in scena in modo che tutti lo riconoscano, fino al pianto.
La verità mai negata.
È di verità che parlava Hannah Arendt, intervistata dalla televisione della Repubblica Federale Tedesca nel 1964 che alla domanda se ritenesse suo dovere pubblicare tutto quello di cui veniva a conoscenza o vi fossero motivi validi per tacere alcune cose, rispose con una frase in latino: fiat veritas et pereat mundus (parafrasando il motto di Ferdinando I d’Asburgo e sostituendo la giustizia con la verità). La verità, anche a scapito del mondo. La verità, mai venduta a peso, scambiata con l’interezza dell’universo. Una frase che se avessi coraggio da vendere mi tatuerei. Una regola aurea di cui non ringrazierò mai abbastanza l’artista ed attivista cubana Tania Bruguera.
La verità indossata.
È verità anche quella di cui si fa portavoce una delle mie felpe preferite, che indosso sempre quando il ciclo guasto delle stagioni inizia a propinarti il freddo più molesto, quello che ti coglie alle spalle mentre tu stai ancora facendo i conti con l’estate e i suoi carichi di meraviglia. Anche la sua è una verità di tempo perduto e dimenticato, ed è anche una call to action. Che a volte indosso nella speranza di saperla trasformare in verità acquisita, ovvero in azione pratica.
La verità scomoda.
È verità da insight creativo quella della campagna di Nike, Winning is not for everyone, lanciata a luglio in occasione delle Olimpiadi di Parigi e proseguita sul profilo Instagram del brand.
Le piccole pillole mi sembrano ancora più capaci di guardare in faccia le diverse sfaccettature del messaggio. “If you don’t hate running a little, you don’t love running enough” caption che accompagna uno dei reel, mi ha immediatamente riportato alle pagine di Open, l’acclamata biografia di Agassi, in cui il tennista confessa: “odio il tennis, lo odio con tutto il cuore.”
Ricordo bene le discussioni sull’argomento, sull’aderenza alla strategia generale di Nike, appena uscita la prima affissione e poi il primo commercial. Sembrava l’antitesi della democratizzazione dell’aspirazionalità declamata da just do it. Ma in effetti, non c’è alcuna antitesi, c’è solo un surplus di verità.
In fondo l’inseguimento della vittoria e la sua conquista stanno nei calzoncini in modo solo del tutto metaforico, ma sono impastati di tutte quelle altre, meravigliosamente umane, manifestazioni come il sacrificio, la capacità di tollerare il dolore, l’istinto di spingersi all’estremo e l’odio che si contrappone all’amore. Solo portando in scena questa contro narrazione, riportando sotto i riflettori ciò che non è confortevole, si chiarisce perché non è dato a tutti stanziarsi sulla cima.
L’aria fresca della vetta, fuori dalla ressa e dal mucchio, bisogna andarsela a prendere raschiando le forze, senza alcuna certezza di non mancare il bersaglio. Tutti possono tentare, certo. Ma confessiamoci che a riuscirci siano in pochi. Che non sono brutte persone, se ce la fanno. E che non lo sono neanche quelle che si fermano al mero tentativo.
Perché la verità è che ciò che sembra facile non lo è e quello che appare difficile, è difficile per davvero.
La verità senza voce.
Ho trovato poi un sacco di verità anche in due brani senza parole. Together dei NIN, spoilera tutto il portato emotivo del primo episodio dell’ultima stagione del già citato The Bear. I funerali di Enrico di Iosonouncane, colonna sonora di “Berlinguer. La grande Ambizione” accompagna quelle forme di addio che marchiano indelebilmente le volte in cui abbiamo dovuto separarci da chi ci aveva tenuto per mano senza dirci che non sarebbe stato per sempre.
Perché le parole non sempre servono, ma la verità è che a furia di non usarle si perdono. E che giro intorno a questa roba qua lo avete già capito (per tutti gli altri ci sono pezzi come “L’errore più grosso” o “I post-it non mentono mai”). Ma domenica c’è stato un upgrade. Ho capito che a furia di non usarla, si perde anche la voce. Me l’ha sussurrato nelle orecchie quell’altra me, quella che si è ritrovata incapace di cantare a pieni polmoni un’alleluia che trent’anni fa avrebbe spedito nell’alto dei cieli, senza nemmeno prendere fiato.
La ritroverò quella lì, dovesse volerci tutto il resto della vita.
La ritroverò, perché sono certa che conoscesse già un sacco di cose vere che si è scordata di lasciarmi in eredità.





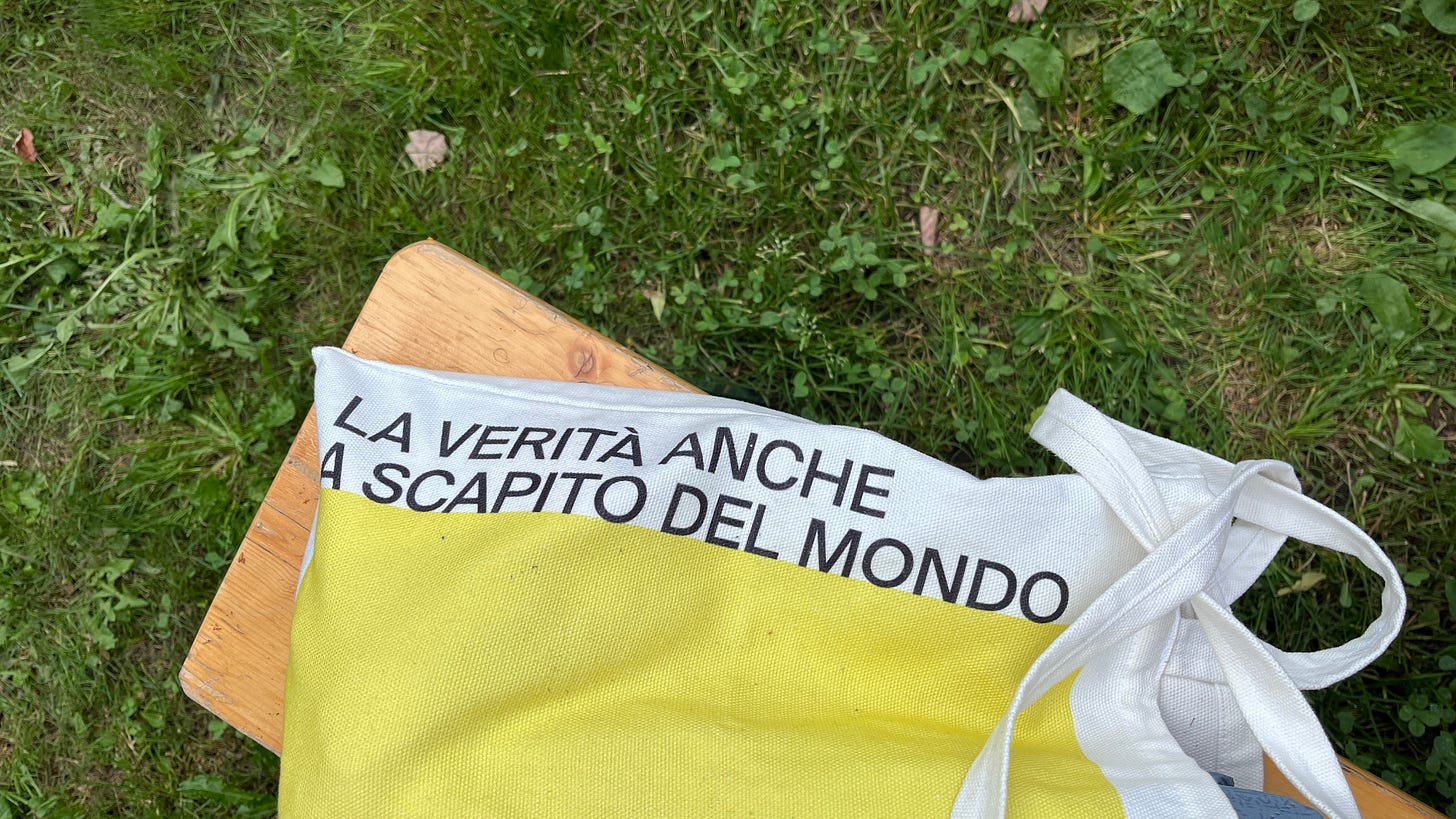
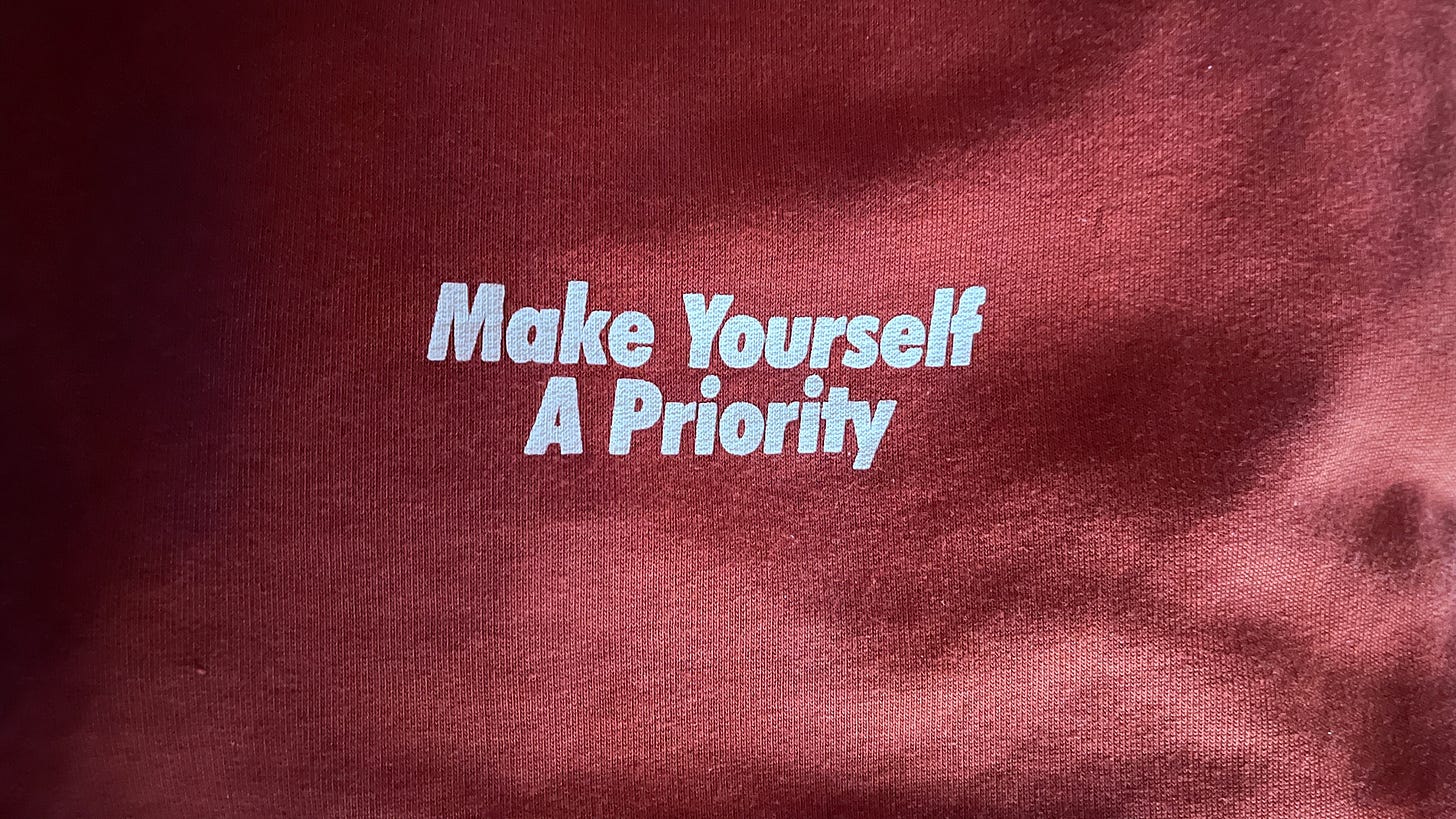

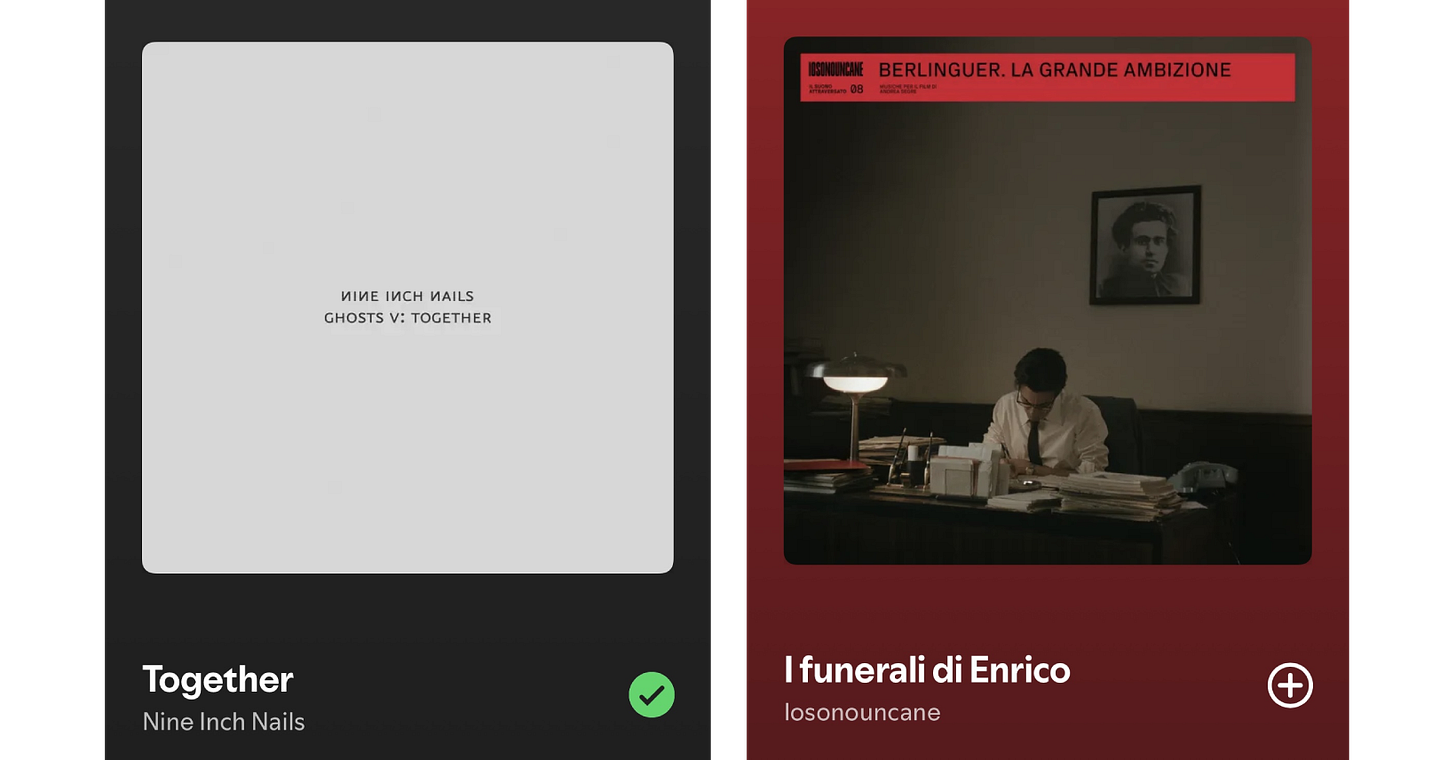
Secondo me non è mai nelle parole la verità, è altrove, è nel non detto, nelle espressioni, nel tono di voce, negli occhi a volte o nel corpo; insomma o la cerchi e te la vai a cavare o è raro ti si palesi, sarebbe troppo semplice. Interessantissima lettura, complimenti❄️